La
figura mistificata del Passatore
In
un contesto siffatto, nel quale nasceva la stessa figurazione pascoliana, la
leggenda del Robin Hood romagnolo si
andò definendo tempestivamente, quando ancora il Passatore era vivo.
E
come tutte le leggende apriva in primo luogo sulla stessa nascita, secondo il
principio che un eroe non può avere che genitori grandi, sicché - come
annotava Dante - occorreva sostituire ai genitori pastori di Romolo e Remo non
solo una principessa, Rea Silvia, ma addirittura una
divinità, in questo caso Marte, dio della guerra.
Per
il Passatore, l'impegno dei favolisti, per
quanto non si giungesse a tanto, fu tuttavia di particolare vigore.
Se
non si pensò a una principessa ed a un dio, si inventò tuttavia una coppia che
non era molto lontana da così alto lignaggio: si scomodò una contessa ed un
papa.
Così,
dopo non molto tempo la morte del Passatore, tale Antiodo Agnolucci pubblicò
con i tipi di Salani un romanzo torrenziale per numero di pagine e per lussuria
retorica, poi ridotto - per mano di Eugenio Rontini e per ordine dello stesso
editore, deciso a far correre più agevolmente le vendite - ad un più snello,
ma non meno immaginifico racconto.
In
tale romanzo, madre del bandito è la contessa d'Alba, aerea fanciulla ch'ebbe a
generarlo con la "collaborazione" del futuro Pio IX, prima che costui
fosse ordinato sacerdote: sicché quel nobile signore della strada, adottato da
un barcaiolo del Lamone, si trovò per tutta la vita costretto a sfuggire la
caccia dei feroci gendarmi del padre.
|
E
perché il romanzesco potesse tracimare oltre ogni decenza, e si potesse dare
libero sfogo all'anticlericalismo - che aveva così grande parte nella
tradizione dei romanzi popolari del tempo appartenenti alla scuola di Gian
Domenico Guerrazzi (e dello stesso Garibaldi) - si inventarono sia Carmela, la
fanciulla amata poi fattasi suora, sia un prete ferocemente in caccia del nostro
eroe, il vicario don Frediano, corruttore e traditore.
Nella
costruzione della leggenda, peraltro, occorreva rendere quanto più possibile
“nobili" le ragioni che indussero il Passatore a scegliere infine la vita
del brigante: non le cattive compagnie, né una nativa propensione alla violenza
o la ferocia inesplicabile e improvvisa di un paranoico, bensì la prepotenza
altrui, l'ingiustizia che si accanisce contro il buon giovane e lo spinge
ineluttabilmente alla macchia.
Così,
per Il nostro eroe, si inventarono una colpa d'amore, che sempre assicura
comprensione, e anzi complicità, e la tenace ferocia di un prete, che così
bene risponde alle necessità di una Romagna anticlericale.
|
|

Giuseppe
Afflitti detto "il Lazzarino". |
Stefano
avrebbe dunque sedotto una giovinetta delle sue parti, che per sventura aveva
come suo protettore don Antonio Morini, detto don Fiumana, arciprete della Pieve
di Cesato.
E
don Morini - il cui interessamento per la pecorella smarrita, dice la leggenda,
era sollecitato assai più da ragioni inconfessabili che da spirito di carità -
prese a minacciare il giovane seduttore perché, come la legge voleva, sposasse
la fanciulla resa madre, o pagasse il debito in galera.
Per
queste ragioni, il povero giovane - malfattore sì, ma malfattore d'amore, che
è colpa lieve - finì in galera a Bagnacavallo, condannato a tre anni.
Ma
poiché l'audacia gli era nativa, e così l'abilità e l'astuzia, il nostro eroe
non tardò a fuggire dal carcere, gettandosi alla macchia, mosso ora da un
ardente sete di vendetta: alla quale dette dopo non molto tempo ristoro,
lasciando morto stecchito il prete maligno, mentre costui passeggiava per una
strada di campagna prossima al suo villaggio, la sera del 23 dicembre 1850.
Dunque,
quel che fece di Stefano Pelloni un masnadiero di sanguinaria ferocia sarebbe
stata una gioiosa colpa d'amore, il nonnulla di un abbandono tra le stoppie ad
una breve ora.
Sicché
ben doveva morire il prete fedifrago e lussurioso, che con così maligna
protervia aveva rovinato la vita di un giovane, spingendolo alla macchia.
Nella
leggenda del Passatore, per vero, troviamo anche una più realistica versione
delle sue origini banditesche, tale tuttavia da mantenergli la figura di
giovane, scapestrato certamente, ma colpito da una giustizia che tra la colpa
commessa e la pena inflitta inserisce una feroce divaricazione.
Per
tale versione - nella quale si confonde tra la biografia del Pelloni e quella di
un altro celebre brigante, Tommaso Montini il Teggione
- le sventure del Passatore sarebbero iniziate sulla piazzetta di fronte
alla chiesa di Pieve di Cesato, dove una lite scoppiata con un coetaneo, che era
naturalmente il provocatore, si trasformò in una sassaiola e si concluse in un
dramma: uno dei "proiettili" scagliati dal nostro eroe adolescente
colpì una giovane sventurata sul sagrato della pieve, lasciandola stecchita.
Per
tale omicidio colposo il giovane finì in carcere; poi
l'evasione e l'ineluttabile vita di brigante alla macchia.
Dunque,
in questa versione, non la volontà di un giovane malfattore che per sua lucida
determinazione sceglie una vita di grassatore e di omicida, bensì uno
sventurato incidente, una sassaiola di adolescente, un lanciar sassi che è
proprio dell'infanzia, e persino del Carducci di Davanti
San Guido.
|

La
presenza angosciante dei briganti trova testimonianza nel significativo
numero di "ex-voto" presenti nella Basilica del Monte di
Cesena, a ringraziamento della positiva conclusione di agguati
briganteschi. |
|
Sicché
la cecità della legge avrebbe armato la mano del Passatore e aperto la sorgeva
che nella Romagna di metà Ottocento avrebbe originato un fiume di sangue.
Anche
così, pur con una morte agli inizi della sua feroce carriera, si garantiva a
Stefano Pelloni un'origine "innocente" e si poteva dare alimento alla
sua leggenda cortese.
La
leggenda, infine, non ignora le romanticherie di amori "nobili", di
relazioni con dame della nobiltà.
Ma
l'incolto bracciante di Boncellino - per quanto possa essere accaduto che una
qualche damina, malata di scadente romanticismo, abbia potuto nutrire una
qualche segreta passione per il malandrino sanguinario - si sarebbe trovato
alquanto fuor di posto in un rapporto del genere.
Da
rozzo e gagliardo figlio della campagna, andava per le spicce, distribuendo il
suo giovanile ardore dove gli capitava e nei momenti più impensati, come
quando, nel bel mezzo del sacco di Forlimpopoli, sbollì le voglie su di una
serva di locanda non certo in odore di verginità.
Altre
femmine le ebbe nei postriboli di paese e in certe case frequentate dai
briganti, fra le quali quella dal nome significativo "delle donne",
dove compiacenti ruffiani combinavano incontri "romantici" tra
grassatori carichi di scudi e mercenarie di provincia.
A
Boncellino frequentava una tanghera nota come La
Rivalona, un
nome che par quasi un manifesto, per quel tanto che evoca di villici amplessi
tra le stoppie del Lamone.
|
E
del resto era questa una situazione normale per tanti giovani di campagna
braccati dalla legge, e perciò evitati dalle fiorenti ragazze da marito, che
allora si concedevano solo se avevano la certezza di essere condotte all'altare.
Nella
leggenda del Passatore non poteva mancare la mistificazione
"politica", cui dette alimento lo stesso Garibaldi, che in una sua
lettera dall'esilio negli Stati Uniti, datata 10 dicembre 1850, ebbe la sventura
di ricordare il Pelloni come un "bravo italiano":
Le notizie del Passatore sono stupende... pare fare prodigi.
Noi baceremmo il piede di
questo bravo italiano che non paventa, in questi tempi di generale paura, di
sfidare i dominatori.
Dimenticando
che l'attività della banda non conobbe tregua nemmeno nel periodo del
triumvirato Mazzini-Saffi-Armellini e della Repubblica Romana (il leggendare ha
sempre bisogno di clamorose amnesie), si caricarono le imprese brigantesche del
Pelloni non solo delle idealità del grassatore che spogliava i ricchi per dare
ai poveri, ma anche di più dirette, consapevoli e men generiche ragioni
politiche, facendone un ribelle allo Stato della Chiesa e anzi giungendo a
considerarlo un protagonista dell'epica marcia di Garibaldi, in fuga attraverso
gli Appennini per raggiungere Venezia assediata: una marcia che il Pelloni
avrebbe accompagnato e favorito, eletto dai mitografi a
patriota di complemento.
Esemplare,
da questo punto di vista, il romanzo Il
Passatore, scritto all'aprirsi del Novecento dal ravennate Bruno Corra,
ancor oggi pubblicato da Garzanti.
Una
mistificazione siffatta è ben comprensibile: rientra nell'usuale lettura per la
quale tutto ciò che si oppone all'autorità costituita, compresa l'impresa
brigantesca sta dalla parte nobile ed eroica della rivoluzione.
Tale
dimensione, in realtà, era del tutto ignota all'illetterato Stuvanè,
che nemmeno per un istante - per educazione ricevuta e per il suo stesso
ambiente di vita - poteva immaginarsi l'anima del giustiziere, del difensore dei
deboli, del ribelle che sogna un mondo nuovo.
Egli
agì sempre nella torva determinazione del suo interesse personale, e se tra i
contadini - quelli che gli assicuravano ospitalità, coprivano le sue fughe,
davano indicazioni e informazioni alla sua banda - corse un fiume di denaro, ciò
fu non per restituire al poveri quanto era stato loro sottratto dalle
ingiustizie sociali , ma sempre e unicamente per mantenere attiva la rete
davvero straordinaria delle sue coperture e delle sue complicità.
|
Confessò
la sorella Lauretana, che più di ogni altro è testimone attendibile: «Non ha
mai dato niente a nessuno: se dava qualcosa lo faceva perché aveva bisogno di
complicità o altro».
Un
eroe di stampo antico, il nobile e l'oppresso, il patriota e il vendicatore, la
primula rossa temeraria e romantica non sono in sostanza che una mistificazione
senza fondamento: i purissimi ideali di giustizia e le parole di un nobile
sentire, che romanzieri e mitografi gli attribuirono, dimenticano che Stefano
Pelloni era un contadino di Boncellino, che la sua lingua era solo e unicamente
l'aspro e duro dialetto romagnolo, che il suo mondo culturale non era più ampio
degli scudi e degli ori delle sue rapine, del sangue spesso versato per pura
ferocia, della morte data non di rado con sadismo, l'unico tra i briganti
dell'intero Ottocento - come ha sottolineato Leonida Costa - che giungeva a
sezionare le sue vittime, abbandonando per la via i resti del suo macello.
Per
questo, la Romagna che se ne fregia come di un suo figlio esemplare e ne empie
le strade con la mistificante immagine di brigante calabrese (compreso il
trombone, un'arma che il Pelloni non usò mai), è una Romagna stretta alle
dimensioni del mito, che solo può comprendersi se, spogliato il Passatore di
tutti i minuti elementi della sua tragica esistenza, non resta che il simulacro
e il fantasma del ribelle, così caro
a una terra di aspre e incorrotte passioni politiche, quella che tra Otto e
Novecento, nel grande quadro delle lotte contadine e bracciantili, si fece madre
feconda di passione civile, dando un contributo vigoroso al formarsi dei partiti
dell'Italia del Novecento.
|
|

Lauretana
Pelloni, sorella del Passatore.
Non diversa immagine di sé doveva dare, sul finire della sua vita, la
sventurata Francesca Errani, madre del brigante. |
In
questo ambiente si ebbe la dissociazione tra storia
e mito,
e il mito ebbe la meglio sulla storia, per la buona ragione che si fa
ovunque dominante - e tanto più tra le angherie e le miserie - il bisogno
dell'eroe positivo, nella cui identificazione e nella cui luce si può
continuare a sperare nella possibilità del riscatto, nella sconfitta dei padroni
del mondo.
La
rottura tra storia e mito, cui hanno
dato energiche spallate le indagini di Leonida Costa,
ha trovato un intrigante luogo di confronto e di discussione nel processo a carico di Stefano Pelloni, che - per iniziativa
del Centro Culturale di Ravenna e del suo animatore Walter della Monica - è
stato celebrato il 18 e 19 giugno 1993 al teatro Astoria di quella città.
In
quella occasione, l'accusa - sostenuta da Piero Casadei Monti, consigliere di
Cassazione - sostenne la tesi della pura criminalità del Pelloni: il brigante
agì nella totale assenza di ideali, di rivendicazioni sociali, di slanci
pre-risorgimentali: un giudizio che la giuria raccolse nelle conclusioni del processo,
collocando il Passatore «in un'ottica esclusivamente individuale, egoistica
e criminale, in funzione dell'avidità di denaro e del vivere senza lavorare».
Ma
già l'accusatore riconosceva la forza del mito, sottolineandone la funzione
consolatoria «nell'attesa di una crescita politica e sociale».
Sicché
lo scrittore Massimo Dursi poteva sostenere: «Moriva col Passatore
un'illusione, scompariva il campione di una rivolta sbandata sì nell'equivoco e
nel delitto, ma - si intuiva - per una condizione disperata e non per trista
vocazione»: un richiamo ai contesti politici e sociali sui quali si era
intrattenuto il criminologo Augusto Balloni, sottolineando le condizioni di
disagio, di abbandono, di inerzia amministrativa della Romagna pontificia, nella
quale quasi il 20% della popolazione sopravviveva grazie all'accattonaggio: una
condizione generatrice di «un ribellismo di tipo risentito, canagliesco».
La
difesa - sostenuta da Gianni Morelli - faceva tesoro di questi rilievi, che la
giuria accolse infine sottolineando che le azioni del Passatore, pur prive di
motivazioni libertarie e politiche, furono generate «dal terribile contesto
economico e sociale».
Ma
nella sua appassionata difesa del brigante, il Morelli andò oltre, collegando l'eroe
di Boncellino alle vicende che dettero vita al carattere libertario dei
romagnoli ottocenteschi e alle loro lotte contro la povertà e l'ingiustizia
sociale: insomma, un Pelloni ribelle politico, detonatore
di una Romagna povera, inquieta, violenta e malgovemata, e perciò, a suo
modo, uno dei protagonisti di quella guerra di liberazione che chiamiamo
Risorgimento: «un frutto aspro, acerbo, ma pur sempre un frutto della Romagna».
Non
a caso, efficacemente, il Morelli costruiva la diade oppositiva tra il
proletario Apollinare Fantini, servo del regime pontificio e uccisore del
Passatore, e il proletario ribelle Stefano Pelloni: «nello scacchiere della
crisi ognuno occupa il proprio posto: Apollinare Fantini, volontario pontificio;
Monsignor Bedini, cardinale persecutore; e Pelloni ha scelto di stare dall'altra
parte.
Pelloni,
figlio della Romagna, nostro fratello».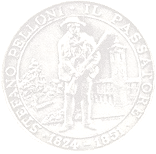
Come
si vede, la dissociazione mito-storia è ancor oggi energicamente attiva.
Per
tale energia il processo di Ravenna si concludeva infine, quanto meno
implicitamente, nel riconoscere con Augusto Balioni che il mito ha una vita
autonoma rispetto alla storia e va perciò guardato con un'ottica diversa: lo
Stefano Pelloni che lasciò una scia di sangue nella sua vita
"storica" non ha nulla a che vedere con l'altra straordinaria figura
del mito, con quel re della strada e re della foresta che alimentò la speranza
del riscatto e signoreggiò nel fuoco delle lotte sociali, ripensato come una
luce dagli oppressi: sicché, nell'Ottocento e oltre, non soltanto fiorirono
centinaia di romanzi, opere di teatro, spettacoli per burattini, romanze
popolari sull'eroe di Boncellino, ma anche poteva accadere che l'avola
favolatrice si chinasse sulle culle dei bimbi per cantare la Cantlèna
dla morta de Pasador.
Il
brigante di strada era diventato - come Fra Diavolo, come Robin Hood, come
Musolino, come Billy the Kid... - l'eroe dei poveri, la voce della incorrotta
speranza di un vindice riscatto.
.gif)



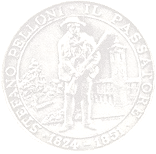
.gif)