La Romagna
pontificia
nell'immobilità del tempo ciclico
|
Per
comprendere il tessuto culturale nel
quale potè nascere tempestivamente, quando ancora il Passatore era vivo, la
leggenda di un Robin Hood romagnolo, che trasformava un malfattore sanguinario nel
re della foresta, non sarà inutile
dare un quadro sia pure sintetico della Romagna ottocentesca.
Come
è noto, caduto Cesare Borgia e ritornata stabilmente sotto il dominio diretto
dello Stato Pontificio, per quasi tre secoli, dal XVI al XVIII, nulla muta nei
territori delle Legazioni.
Nelle
campagne romagnole, la vita è quella dei contadini di un tempo povero e avaro,
fatto di soggezione e di miseria, quando non anche di pesti e carestie, che si
alternano con frequenza tanto nelle città quanto nel contado.
Il
tempo è scandito dal ciclo agrario (la semina, il raccolto, la mietitura, la
vendemmia, il governo e l'allevamento del bestiame...), senza nessuna
prospettiva: gli anni - come annota R. Camporesi - si ripetono allo stesso modo,
in un tempo ciclico nel quale la povera gente dei campi non ha nemmeno
consapevolezza di un possibile cambiamento, di un tempo come modificazione
e sviluppo: gli anni si ripetono, simili
tra loro.
|
|
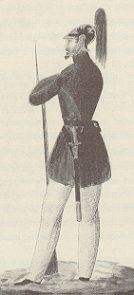
Guardia
Civica in alta uniforme. |
Certo,
vi è la varietà della vita: le feste durante la mietitura, la vendemmia, la
macellazione del maiale; gli incontri domenicali nei luoghi di culto e quelli
serali nelle stalle (e’ treb), durante
i quali, così come nelle feste del ciclo agrario, i giovani hanno possibilità
di incontrarsi.
Ma
spesso anche questi momenti di incontro sono guardati con preoccupazione dalle
autorità, che talora intervengono per limitare la mobilità dei contadini: la
Chiesa ed i proprietari terrieri considerano spesso persino i trebbi
come una pericolosa abitudine e talora li proibiscono, come avviene di norma
durante la dominazione pontificia, quando erano considerati pericolosi per
l'ordine pubblico e per la moralità.
E
del resto, ancora nella seconda metà dell'Ottocento, negli anni del Regno
d'Italia, quando oramai era impossibile vietare quelle riunioni, esse venivano
tollerate come un male inevitabile.
Negli
Atti della Giunta per la Inchiesta agraria e sulle condizioni delle
classi agricole, risalenti al 1881, si può leggere che i trebbi
«prendono sempre più incremento; vi si gioca e vi si balla; incentivo al
furto ed al delitto, all'immoralità ed al vizio.
Difficile
ormai impedire o diminuire questo male».
Così
come si proibiscono le feste del cielo agrario e la stessa libertà di
movimento, ai contadini - per contratto - viene vietato di frequentare le
osterie.
Essi,
inoltre, non debbono partecipare a feste, non debbono recarsi in città, ad
esclusione dell'azdor, ma solo per frequentare il mercato o per bisogni comunque
connessi alle necessità del podere.
L’incontro
è luogo di dialogo e il dialogo conduce alla riflessione, a nuove
consapevolezze.
Per
questo è necessario tenere le singole famiglie contadine nel loro isolamento,
nel quale il tempo ciclico delle
campagne e l'assenza del confronto permettono un più facile controllo,
impedendo l'insorgere del tempo come svilippo
e modficazione.
Non
a caso, nei contratti mezzadrili si incontra frequentemente la proibizione di
farsi aiutare, nei momenti di emergenza (la raccolta del grano, la vendemmia
...), dalle famiglie contadine dei poderi vicini.
|

Il
Passatore sul palcoscenico del teatro di Forlimpopoli in una stampa del
secolo scorso. |
|
E
quanto alla libertà di movimento si legge in un altro contratto del tempo: «non
sarà tollerato che gli individui della famiglia colonica frequentino i mercati
e le fiere senza giusto motivo da conoscersi dal Proprietario o suoi Agenti».
In
questa serie di limiti e proibizioni rientravano anche questioni centrali della
vita personale: il contadino, per sposarsi, doveva ottenere l'autorizzazione del
padrone e doveva "figliare con giudizio": e ciò perché, come si
legge nel contratto citato, «l'aumento o la diminuzione del personale della
famiglia può alterare l'economia del fondo».
Si
giungeva addirittura a metter mano ai modi del vestirsi, proibendo «il vestire
e trattarsi con lusso superiore a quanto richiede la loro condizione»
La
stasi e l'immobilismo dei secoli XVI-XVIII sono rotti dal grande evento della
Rivoluzione francese e delle guerre napoleoniche, che scardinano per la prima
volta assetti lungamente consolidati.
|
Per
la gente dei campi, tuttavia, questi eventi non possono significare apertura di
nuove prospettive: se nella vicina città si issa il vessillo della rivoluzione,
si proclama la repubblica, si innalza l'Albero della Libertà e si progetta un
nuovo mondo, le famiglie contadine che formicolano in terre spesso avare e
paludose, piegate nella loro fatica, non hanno percezione che si vanno
costruendo nuovi valori.
L'azione
della Chiesa - colpita dalle spoliazioni rivoluzionarle e dall'abbattimento
della sovranità temporale del Papa - costruisce anzi tra le popolazioni
contadine atteggiamenti ostili verso la rivoluzione, opera del demonio.
Senza
contare che nulla muta in effetti per il lavoratore dei campi.
E
anzi alla sua secolare condizione di sottomesso si aggiunge ora la predazione
degli eserciti, che requisisce frutti della terra e bestiame.
Così,
i danni recati dal passaggio delle truppe dell'Austria, dei Borboni, dei Savoia
lasciano segni durevoli nelle campagne, ove talora i combattenti soggiornarono a
lungo.
Elemento
ancora più grave è che ora per la prima volta è introdotta la coscrizione
obbligatoria, e ciò determina casi di diserzione, che danno nuovo alimento
all'esercito dei briganti.
Dopo
il Congresso di Vienna, con la restaurazione dei regimi che avevano preceduto la
stagione rivoluzionaria, i sovrani d'Europa si illusero che la parentesi
napoleonica si fosse chiusa per sempre.
Ma
essa aveva celebrato i valori della democrazia e costruito in molti l'idea di
unità nazionale; gran parte del sec. XIX è la storia del risorgimento
dei popoli (italiano, greco, belga, ungherese ...), impegnati ad affermare
l'indipendenza delle Nazioni ed a costruire gli ideali liberali di uno Stato
costituzionale.
Da
noi è il tempo delle insurrezioni carbonare, dell'apostolato di Giuseppe
Mazzini, dell'azione diplomatica e militare dei Savoia, delle insurrezioni di
popolo che condurranno infine alla costituzione del Regno d'Italia.
Le
popolazioni delle campagne non parteciparono dapprima a questi eventi, se non
molto marginalmente, chiuse in un’arretratezza che impediva loro di intendere
i significati dell'azione risorgimentale.
La
storia delle generazioni che nel corso del primo Ottocento vissero nelle
campagne romagnole si svolge prevalentemente su un altro piano, quello di una
quotidianità che si ripete, lontana dai fermenti, e anzi spesso ostile alle
novità, che vanno intanto costruendo un mondo nuovo.
Sconfitto
Napoleone e restaurato lo Stato della Chiesa, le campagne romagnole, in attesa
del loro futuro splendore, si presentavano con un volto che non saremmo
assolutamente in grado di riconoscere: dove oggi ci sono orti e frutteti - talché
i campi appaiono al forestiero che li
attraversa come un geometrico giardino - si stendevano non di rado vasti
latifondi o ampie unità poderali, i cui proprietari (famiglie nobili, Chiesa,
conventi e monasteri) non possedevano nessuna mentalità imprenditoriale.
Per
questo non vi era segno di opere di bonifica o di introduzione di nuove culture,
ma solo si badava a sfruttare la terra per quel che essa poteva dare
nell'immediato.
Dove
ora sono disegnate le «campagne geometriche di Romagna» (Carlo Levi) si
distendevano campi occupati per la metà dal grano; per un'altra grande parte da
mais, canapa, fagioli e fava; per una piccola parte da erba medica, trifoglio,
avena...
Nella
Romagna del nord-est, che fu più ampio teatro delle imprese del Passatore,
poteva scorgersi un ancor più triste paesaggio, rotto dalle frequenti piene dei
fiumi e perciò occupato in parte rilevante da acquitrini o lasciato al pascolo
e all'incolto.
Tra
le valli e i boschi che si distendevano tra Fusignano e Conselice, Lugo e
Argenta, le poche abitazioni altro non erano che capanne in legno e canne
palustri ed i villaggi, ai margini delle grandi tenute, null'altro che un
insieme di squallidi abituri: una Romagna stretta dalla fame, che sopravviveva
spesso in virtù degli antichi diritti di legnatico, fogliatico e pascolo, oltre
che con la caccia alle folaghe ed la pesca; una Romagna di diseredati, votata a
una vita di stenti, muta nella subordinazione ai possidenti, i cui gesti
potevano essere per gli sventurati e per le loro famiglie ragione di vita o di
morte.
E
si può allora comprendere come in alcun di loro, specie tra i giovani,
non ancora educati alla rassegnazione, la scorciatoia della malavita
apparisse l'unica via per dichiarare il diritto alla vita.
All'indomani
della Repubblica Romana, e dunque negli anni centrali della tragica avventura del Passatore, agli usuali gravami del governo papalino si aggiunse la presenza
degli Austriaci, che erano venuti in soccorso del Papa contro il governo
repubblicano di Saffi, Armellini, Mazzini e che mantennero a lungo il controllo
militare e poliziesco dello Stato della Chiesa.
In
questo quadro - nel quale le popolazioni sono colpite da gabelle sempre più
pesanti, dalle requisizioni di bestiame, dalle angherie dell'esercito austriaco,
dalla ferocia dei suoi tribunali - il malcontento più largamente dilaga, senza
che più possa essere tenuto a freno dall'opera del clero: esso matura per la
prima volta anche nelle campagne e spiega la futura vasta adesione della Romagna
ai plebisciti del 1859 per l'annessione delle Legazioni allo Stato di Sardegna.
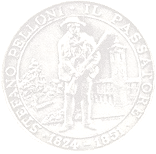
.gif)
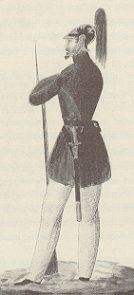

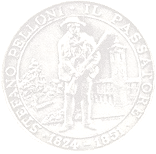
.gif)