| "Contra i pinsìr un gran rimedi l'è e' bicìr" (contro i pensieri un gran rimedio è il bicchiere), sentenziava il romagnolo dei tempi poveri della nostra terra, quando molte sere doveva accontentarsi di riempire lo stomaco con una cipolla ed un po' di piadotto fatto più di farina di fromentone che di grano. | |||
|
Ed esprimeva allora il suo ideale di vita con questo proverbio: |
||
| "Pán ad gran, ven 'd tarbiàn, fug 'd querza, e una bela dona, nenc s'l'è guerza! " (pane di grano, vino di trebbiano, fuoco di quercia, e una bella donna, anche se è guercia). | |||
Il trebbiano era tenuto dunque nella stessa considerazione del pane di grano, del fuoco di quercia e di una bella donna sia pure con un leggero difetto! |
|||
Da una lezione ravennate dell'antica canta della "Donna Lombarda" si apprende che la regina Rosmunda offre al marito assetato di scegliere fra il vino bianco e quello rosso; si doveva trattare certo di trebbiano e di sangiovese. |
|||
I due vini, infatti, non mancavano mai nelle cantine dei vecchi romagnoli che offrivano o l'uno oppure l'altro, immancabilmente all'ospite, fosse un ricco signore o un mendicante, rispettando così l'antico rito della sacra ospitalità. |
|||
E l'ospite contraccambiava l'offerta versando le ultime gocce del bicchiere sull'arola: la piccola ara, per rendere così omaggio agli dei della casa effigiati negli alari. |
|||
Un rito millenario giunto, si può dire, quasi ai nostri tempi! |
|||
Per il romagnolo il vino è sempre stato sacro, quasi come quello che Cristo, mediante il sacrificio della Messa, trasforma nel suo sangue. |
|||
Gli antichi, infatti, ritenevano il loro buon vino rosso sangue di Giove: "e' sanzves" (il sangiovese). |
|||
E per passare alle leggende non si può dimenticare che Galla Placidia, dopo aver libato la dolcissima albana di monte Cesubeo, sentenziò che quel nettare, anziché in vili ciotole di legno, andava bevuto in coppe d'oro, suggerendo così a quegli abitanti il nome di Bertinoro per il loro amenissimo colle. |
|||
E diede pure nome, sempre in virtù di quel vino, anche ad una piccola località del Ravennate chiamata d'allora Gambellara per via del capitombolo fatto nel fosso coll'imperiale cocchio da lei e dal suo automedonte anch'egli troppo inebriato dal vino bertinorese. |
|
||
L'albana, dolce o secca, è definita la regina della collina, come il trebbiano è il re della pianura. |
|||
E non bisogna dimenticare "l'adorabile cagnina", come la qualifica Jacopo Landoni, un poeta del secolo scorso che al buon vino di Romagna ha dedicato più di un verso e forse anche più di una sbornia! |
|||
Gianni Manzoni riporta, nel suo libro sulla vite ed il vino romagnolo, un ditirambo sulla cagnína: |
|||
Cagnina, cagnina |
|||
ti bevono i frati tutti beati, |
|||
ti bevono i preti tutti lieti, |
|||
ti bevono i re fino alle tre, |
|||
ti beve il padrone a colazione, |
|||
ti bevo anch'io grazia di Dio. |
|||
A proposito di frati bevitori c'è da ricordare che "Frè Pignàt e dbeva e' sanzves int la bocia de lat" (Frate Pignatta beveva il sangiovese nella bottiglia del latte), così il fraticello passava per sobrio e magari astemio di fronte ai confratelli! |
|||
Di cagnina una volta se ne produceva dell'ottima nel territorio di San Pietro in Vincoli, San Zaccaria, Castiglione e Pisignano, ora la sua produzione, purtroppo, è molto scarsa. |
|||
Si trattava di un vino rosso, dolcissimo, profumato di viola che andava bevuto nel gotto di terra ed era di rito la sera di Santa Caterina (25 novembre) berne in abbondanza mentre si mangiavano le caldarroste assieme a parenti ed amici appositamente invitati. |
|||
Anche le sere di San Simone (28 ottobre) e di San Martino (11 novembre) si solevano fare delle grandi bevute in allegra compagnia: |
|||
| "Par San Simon us fora la bota de cantòn" (Per San Simone si fora la botte dell'angolo); si cominciava, cioè, a spillare il vino buono dopo che si era esaurita la scorta di quello rimasto in piccoli recipienti e bottiglie perché non aveva trovato collocazione nelle capaci botti di rovere. | |||
| "Par San Martèn us bev e' bon ven" (Per San Martino si beve il vino buono). | |||
Usanza questa antichissima che si confonde colle bacchiche brumalia quando uomini mascherati da caproni amavano apparire becchi all'aspetto e forse anche nella sostanza! |
|||
|
Il Landoni, da buon bevitore qual era, dopo aver giustamente lodato la cagnina, si sofferma a riverire con particolare impegno il "Santo protettor Giovese" che andava a bere nelle osterie famose ai suoi tempi, dalla Zabariona, dalla Pifania, dalla Sartina, da Cagò e da Mastellina; imitato più tardi dal suo discepolo in fatto di poesie scanzonate, di burle e di bevute, Olindo Guerrini che, a proposito della Zabariona, famosa già per aver ospitato e dissetato nel 1848 nientemeno che Giuseppe Garibaldi, scrive che serviva ai suoi clienti boccali di canena romagnola e di marascone pugliese, che, brusco ed alcolico com'era, costituiva un toccasana per il popolo allora assai minacciato dalla malaria. | ||
Ma il poeta che ha cantato maggiormente i vini di Romagna è stato l'abate forlivese Giuseppe Piolanti il quale, come il Redi per quelli toscani, ha composto un vivace ditirambo esaltando tutti i vini della nostra terra e le località che li producono nella gamma delle loro molteplici varietà. |
|||
E canta così il trebbiano di Maiano e quello di Grisignano, il sangiovese di Bertinoro e delle colline riminesi ed enumera tutti i vini minori, quali il moscatello, l'aleatico cui noi potremmo aggiungere il barzamino ed il forte e rodolente "pagadebit", vanto delle cantine di Max David e di Mario Pezzi! |
|||
Da buon romagnolo l'abate Piolanti non può soffrire gli intrugli esotici come quelli ancor oggi purtroppo in voga e canta: |
|||
|
|||
All'ottimo sangiovese di Predappio dedica alcuni nobili versi Luigi Ranieri nel suo poemetto didascalico "La coltivazione dell'anice". |
|||
Vino e poesia sono sempre andati d'accordo fin dai tempi di Orazio e di molti poeti che l'hanno preceduto. |
|
||
In Romagna ce ne dà nobile testimonianza, oltre il Guerrini anche Giosuè Carducci che in grazia dell'amabile vino della contessa Silvia Pasolini Zanelli e dell'arciprete di San Donato, si innamorò della Romagna e si indusse, lui fiero anticlericale, a cantare la chiesa di Polenta! |
|||
E poi c'è il nostro Aldo Spallicci che ha dedicato alcun delle sue ultime e belle poesie ai nostri vini. |
|||
| E per concludere non posso tralasciare che Federico Schurr, il glottologo tedesco che ha trascorso, si può ben dire, tutta la sua vita a studiare il dialetto romagnolo, richiesto dal suo editore in che modo volesse essere pagato dei suoi diritti nei riguardi del libro "La voce della Romagna", gli rispose che voleva essere pagato con tante bottiglie dell'ottimo vino della nostra terra. | |||
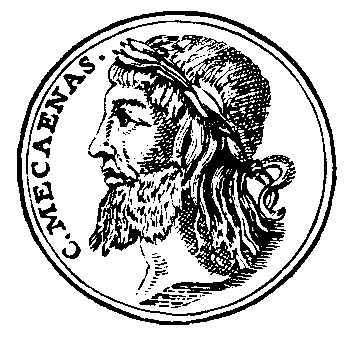
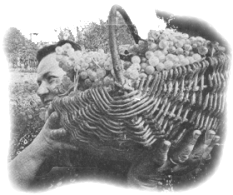
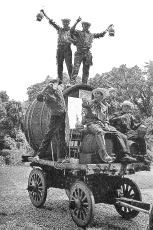
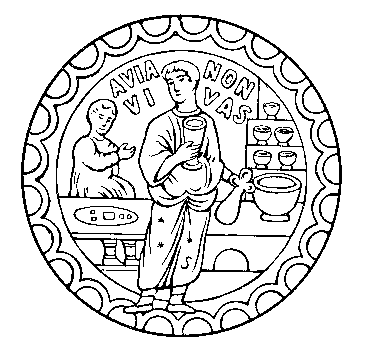
.gif)